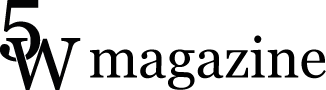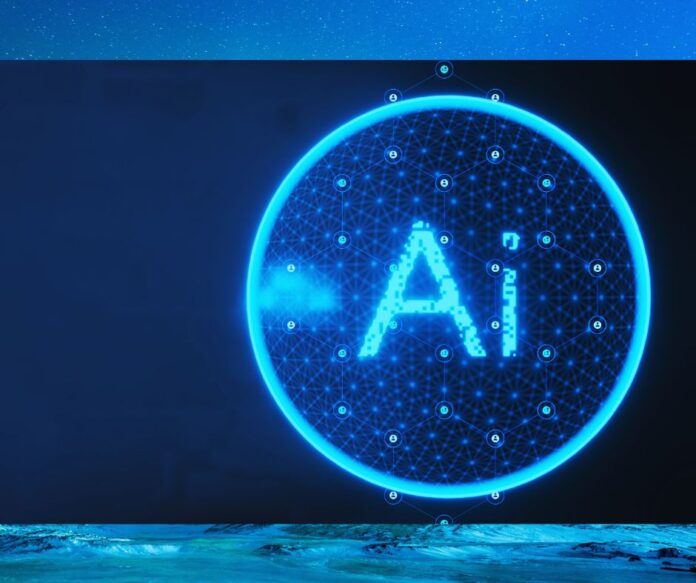Nel mondo, il settore industriale – e non solo quello – è alle prese con un mutamento radicale causato dallo sviluppo dell’Intelligenza artificiale (AI nel gergo informatico corrente) e come primo risultato del cambiamento in atto presenta il conto: taglia posti di lavoro.
Secondo molti sociologi, a tutti gli effetti l’AI è una rivoluzione industriale. La quinta. Cruciale come quelle che l’hanno preceduta, anche se gli effetti indotti dalla ‘industria 4.0’ non sono ancora del tutto avvertiti né prevedibili. Come già avvenuto nelle rivoluzioni industriali precedenti: macchina a vapore (’700), elettricità e motore a scoppio (1870 circa), informatica ed elettronica (anni ’70), automazione cyber-fisica e connessione digitale (inizi XXI secolo), anche quest’ultima innovazione comporta rischi per il mercato del lavoro. Mestieri, lavori e professioni verranno progressivamente soppressi, sostituiti dalle nuove tecnologie. Per dire: già nei primi dieci mesi di quest’anno, negli Stati Uniti sono state licenziate più di un milione di persone, più 44% rispetto all’anno precedente.
Lo scenario lavorativo italiano non è immune da questa allarmante tendenza globale; secondo le stime, entro il 2030 il 39 per cento della nostra forza lavoro necessiterà di aggiornamenti professionali. Per mantenere il proprio ruolo, il 27% dovrà sviluppare nuove competenze, il 22% sarà coinvolto in una collocazione verso ruoli emergenti. Se sarà così, piuttosto che una semplice perdita netta si dovrà parlare di profonda trasformazione del mercato del lavoro.
Più veloce e diffusa di Internet
La differenza tra questa rivoluzione e le precedenti sta nella velocità del cambiamento di paradigma. L’Intelligenza Artificiale sta crescendo a una velocità mai vista prima. Per capire di che si parla: in soli diciassette mesi ChatGPT ha raggiunto 800 milioni di utenti, la maggior parte dei quali per altro al di fuori del Nord America. In due anni (2024), questo sistema ha raggiunto 365 miliardi di ricerche, quando per raggiungere lo stesso volume di richieste sul suo motore, il più diffuso al mondo, nel 2009 Google di anni ne ha impiegati undici.
L’intelligenza artificiale è indubbiamente la tecnologia della storia che si è diffusa più rapidamente. Lo pubblica il primo report di Microsoft sul tema, AI Diffusion Report, sviluppato da Microsoft AI for Good Lab: con oltre 1,2 miliardi di utenti raggiunti in meno di tre anni, l’AI ha un ritmo di adozione superiore a quello di Internet, dei personal computer e degli smartphone.
Tra la popolazione in età lavorativa l’Italia, dove il 77% della popolazione fa uso di uno smartphone (siamo il quinto Paese al mondo per diffusione di telefoni cellulari), si registra un tasso di propagazione dell’AI del 25,8%; leggermente al di sopra della media del Nord Globale (23%), vicino a Stati Uniti (26,3%), ma molto più basso rispetto a Francia (40,9%), Spagna (39,7%) e Regno Unito (36,4%).
Minaccia o realtà?
Il “Future of Jobs 2025” del World Economic Forum riporta che l’86% delle aziende italiane identifica queste tecnologie come fondamentali per la propria evoluzione. Secondo il rapporto Censis-Cooperative “Economia Artificiale. Esposizione del mondo del lavoro e delle imprese alla diffusione dell’IA” (marzo 2025), l’avanzata dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo il mercato del lavoro. A soffrirne saranno i lavoratori impiegati in mansioni ripetitive basate su routine e standardizzazione, in particolare in settori come l’industria manifatturiera (operai di fabbrica, addetti all’assemblaggio), la logistica e il magazzinaggio (magazzinieri), il commercio al dettaglio (cassieri, addetti alle vendite) e i servizi amministrativi (contabili, tecnici bancari). Sono a rischio anche ruoli intellettuali automatizzabili, come giornalisti, traduttori, redattori, copywriter e creativi pubblicitari poiché l’IA può generare contenuti scritti e creativi. Pure alcuni ruoli IT come Data Scientist e Software Engineer sono considerati a rischio parziale.
Una notizia in particolare richiede riflessione: citando stime della Banca d’Italia, il report sottolinea come in Italia circa 4,75 milioni di lavoratori siano “altamente esposti al rischio di sostituzione”. Anche se certe conclusioni possono apparire affrettate, è vero che il rischio paventato di espulsione dal mercato del lavoro esiste. Non è difficile quindi figurarsi la ricaduta di conseguenze negative sul piano economico e su quello sociale. Questa però potrebbe non essere una verità assoluta; in un paper del 2015: “Technological Change and Labour Market Disparities in Europe”, Gregory et al. analizzano l’impatto della computerizzazione del lavoro in 27 paesi europei e dimostrano come questo processo tra il 1999 e il 2010 abbia portato a un aumento netto pari a 11,6 milioni di posti di lavoro (Econopoly, dic.2016). Il 61% delle aziende italiane – informa il sito lifeandnews del 11 giugno 2025 – ha già avviato la transizione verso un modello organizzativo basato sulle competenze, dato più elevato rispetto alla media globale (55%), mentre un ulteriore 20% prevede di farlo entro l’anno. Secondo una ricerca di Workday l’85% dei leader italiani ritiene che questo favorirà la crescita economica.
Criticità diffusa
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un livello di istruzione più alto non protegge dal rischio di sostituzione; anzi, cresce con il titolo di studio. Tra i lavoratori più esposti, “il 54% ha un’istruzione superiore e il 33% una laurea. L’analisi di genere mostra che le donne sono mediamente più colpite, rappresentando il 54% della forza lavoro ad alto rischio.
Questa dinamica suggerisce una possibile ristrutturazione del mercato del lavoro, con effetti sulle disuguaglianze salariali e sulla coesione sociale. Per quanto riguarda il genere, le donne sono mediamente più colpite dagli effetti dell’introduzione delle IA nel mondo del lavoro. Infatti, nella classe ad alta esposizione di sostituzione, il 54% è costituito da lavoratrici e, analogamente, nella sezione dei lavori ad alta esposizione di complemento il 57% sono donne. Inversamente, tra i lavori a bassa esposizione il 71% sono uomini”. Questo scenario è aggravato dal ritardo del nostro Paese nell’adozione dell’IA, che nel “Government AI Readiness Index 2024” si posiziona solo al 25° posto.
Eclissi del ceto medio
Il ceto medio italiano ha subito un drastico declino, passando dal 70% del 2003 al 35% nel 2025, entrando in una profonda crisi identitaria (Ersaf, settembre 2025). Secondo i dati Istat, ancora nel 2023 oltre il 60% delle famiglie italiane si collocava in quella che viene definita “classe media”, le cui caratteristiche storiche: sicurezza economica, stabilità lavorativa, possibilità di accumulo e consumo stanno subendo una mutazione importante. L’Ocse ha calcolato che nell’ultimo decennio in Italia il potere d’acquisto è sceso del 6%, mentre il costo dei beni essenziali: utenze domestiche, cibo, medicine è aumentato ben oltre l’inflazione. Eppure, sia pure attraversando una situazione precaria, il ceto medio resiste. Nei prossimi anni potremmo assistere a sfide significative in termini di occupazione, istruzione, etica e governance. Inoltre, fra le paure più comuni c’è quella che l’IA in un futuro ormai prossimo possa agire senza l’intervento umano.
“Il rischio principale è che la scomparsa della classe media e il fallimento delle politiche (quando ci sono) di redistribuzione delle ricchezze peggiorino anziché migliorare” (Wired, 2023). Sostiene il quotidiano economico on line Italia informa (maggio 2025): in Italia il ceto medio, a causa di incertezza economica e fiscale, erosione del potere d’acquisto e della capacità di spesa, stagnazione dei redditi e pressioni sociali, sta attraversando un periodo critico. L’intelligenza artificiale (sul punto i pareri sono controversi) rappresenterebbe contemporaneamente una potenziale minaccia e una opportunità per il ceto medio. Come sempre in presenza di innovazioni radicali, dipenderà dall’uso che se ne farà. Le decisioni prese nei prossimi anni determineranno se questa classe sociale riuscirà a adattarsi e prosperare nell’era dell’IA o se sarà destinata a un declino irreversibile. All’evidenza è fondamentale agire ora per preservare la coesione sociale e garantire un futuro sostenibile per tutti.
Deepfake e disinformazione
L’AI generativa – commenta IBM sul suo sito on line – ha semplificato la creazione di deepfake, audio, video e immagini realistici ma falsi, utilizzati per diffondere informazioni non vere e manipolare l’opinione pubblica. Ciò pone sfide per l’integrità delle informazioni e la fiducia dei media. Per affrontare questo problema sono necessari strumenti di rilevamento avanzati, educazione pubblica e possibilmente misure legali per ritenere responsabili i creatori di deepfake dannosi. Nel prossimo decennio, queste relazioni potrebbero diventare più profonde, sollevando questioni psicologiche ed etiche. La società deve promuovere reciprocità sincera con macchine sempre più simili a quelle umane, e aiutare le persone a distinguere le interazioni umane autentiche da quelle basate sull’AI. Compito non facile, che potrebbe richiedere tempi generazionali.
Quale futuro?
Dunque, quale futuro dobbiamo attenderci? Il futuro dell’AI vedrà l’integrazione di sistemi multimodali più sofisticati, agenti autonomi capaci di interagire con il mondo reale e un impatto significativo su settori come la sanità, l’industria e la finanza. Conclude il menzionato rapporto Censis: “Risulta evidente l’importanza crescente che la formazione avrà in futuro nell’ambito delle nuove tecnologie, contestualmente al mantenimento della specificità umana all’interno dei processi produttivi”.
L’impatto finale dell’IA, sembra di capire, dipenderà da come le aziende, i governi e i lavoratori affronteranno la transizione. La chiave sarà un approccio equilibrato che sfrutti i benefici dell’IA per l’efficienza e l’innovazione, mitigando al contempo i rischi attraverso la formazione continua e l’investimento nelle competenze umane irripetibili, che sono caratteristiche uniche: il linguaggio articolato, il pensiero astratto, la cultura cumulativa, l’autocoscienza, il libero arbitrio e la capacità di creare e utilizzare la tecnologia in modo complesso, elementi costituenti la specificità umana citata nel rapporto.