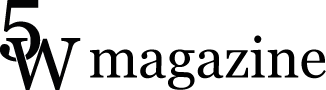Analizzando la copiosa documentazione letteraria disponibile di fonte storiografica, per preparare una conferenza sulla partecipazione del mondo femminile alla lotta di Liberazione 1943-1945, ho rilevato un fatto: i ‘partigiani Johnny’ nello story telling, nella narrazione dell’esperienza ribellistica nazionale, sono molto più numerosi delle ‘Agnese che vanno a morire’.
Mi sono domandato come mai il partigiano, spesso rappresentato come un eroe, vicino alla popolazione, che sacrifica tutto per il bene comune, è prevalentemente un mito maschile? Perché, persino a sinistra, delle donne resistenti si è parlato molto meno, in tutti i sensi? Perché addirittura fu loro scoraggiata la partecipazione alle sfilate celebrative post 25 aprile?
La letteratura post-resistenziale, che racconta la lotta armata dei partigiani durante la Resistenza in Italia, tende a mettere in evidenza principalmente gli uomini come protagonisti perché la maggior parte dei partigiani erano uomini: esercito allo sbando dopo l’8 settembre, renitenza alla leva saloina…; un dato che rifletteva anche la realtà sociale dell’epoca, le mogli e madri erano forgiate dalla cultura e dalla propaganda del Ventennio; impossibile ignorare la tradizione culturale cattolica… elementi che sommati relegavano le donne italiane in ruoli più tradizionali e meno visibili. Conseguenza: nei testi letterari di derivazione resistenziale le donne spesso sono state decisamente meno rappresentate
Eppure “le donne combatterono nella Resistenza, ma combatterono per chi?” e, soprattutto, per che cosa? Se lo chiedeva già Giuliana Beltrami su Effe nell’aprile del’75 commentando: «la guerra e la politica non sono mansioni femminili. Alle donne si chiede magari, in circostanze eccezionali, di offrirsi al piombo nemico sventolando una bandiera. Servono a dare la misura di una disperazione. Se sono giovani e belle è meglio ancora poiché servono di sprone al maschio e possono venire utilizzate come soggetto di quadri e commoventi oleografie. Ma il loro intervento diretto ha una funzione solo in quanto è eccezionale».
Rammentava ulteriormente la Beltrami: «Le donne riconosciute partigiane combattenti furono circa 35.000, di cui 512 con il grado di commissario politico». Molte donne, come Wilna Marchi (Nadia) nella brigata “Stella”, Flora Cocco (Lea) nel battaglione “Amelia”, Gisella Floreanini nella repubblica dell’Ossola, svolgevano questo ruolo. Floreanini fu la prima donna a ricoprire un incarico governativo nella repubblica dell’Ossola, anche a livello di reparto». Eppure…
Per il vero, negli ultimi decenni (c’è voluto il femminismo e il Sessantotto!) c’è stata una maggiore attenzione a valorizzare anche le storie delle donne partigiane; il quadro di questa parte della storia nazionale ora appare più completo, inclusivo e certamente non più in discussione. “Sebben che siamo donne, paura non abbiamo…”, il noto canto di protesta del proletariato conserva ancora la sua smaglianza.